Benvenuta Ilaria tra le pagine de ilRecensore.it, la rivista letteraria pensata per tutti i protagonisti di questa meravigliosa passione che è la lettura.
ILARIA TUTI

Ilaria Tuti, scrittrice friulana sempre in vetta alle classifiche, pubblica con Longanesi il suo nuovo romanzo, Risplendo non brucio, una storia che si dipana sul filo della Guerra mondiale, tra Trieste e Kransberg.
Ha esordito nella narrativa con Fiori sopra l’inferno, creando il commissario Teresa Battaglia, personaggio che ha conquistato editori e lettori in tutto il mondo, e soprattutto la terra natia dell’autrice, la sua storia, i suoi misteri. Il secondo romanzo, Ninfa dormiente, è del 2019.
Con Fiore di roccia (2020) Ilaria Tuti celebra un vero e proprio atto d’amore per le sue montagne, dando vita a una storia profonda e autentica. Nel 2021, con Luce della notte e Figlia della cenere, torna alle storie di Teresa Battaglia.
È inoltre autrice del romanzo Come vento cucito alla terra (2022), ispirato alla vera storia delle prime donne chirurgo durante la Grande Guerra. Nel 2023 esce Madre d’ossa, un nuovo caso per Teresa Battaglia. I suoi romanzi sono pubblicati in 27 Paesi. Da Fiori sopra l’inferno e Ninfa dormiente sono state tratte le omonime serie tv con Elena Sofia Ricci, in onda su Rai1.
“È sul fragile equilibrio di una umanità dissacrata, che si muove il nuovo romanzo di Ilaria Tuti: Risplendo non brucio. Un’opera intensa, che ci riporta in quel tempo in cui l’uomo ha inferto alla Storia il colpo più infame.”QUI la nostra recensione
Con la tua recente opera, Risplendo non brucio, si torna a parlare di orrore vero, quello della follia nazista, ma il momento che hai scelto di raccontare è quello di maggior debolezza del Reich, siamo nel 1944 dopo l’attentato a Hitler. Perché quel preciso momento?
«Perché i momenti chiave di una singola esistenza, come di una comunità, quelli di profonda svolta o definitiva caduta, si misurano sempre durante le crisi, mai nell’equilibrio, o nel successo.
È una legge di vita, nonché narrativa: noi siamo le azioni che compiamo, le scelte che facciamo, non le parole con cui scegliamo di definirci o con cui gli altri raccontano la visione che hanno di noi, e questo vale anche per i personaggi di un romanzo. Possiamo affermare, del tutto in buonafede, di essere persone perbene, decisamente migliori di altre, ma nulla in noi è così monodimensionale.
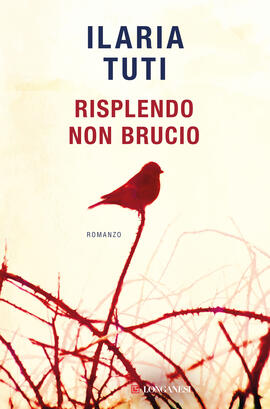
Allora, in difficoltà, che cosa saremmo capaci di fare, pur di sopravvivere? A che cosa saremmo disposti a rinunciare, pur di salvarci? Queste sono le domande che attraversano l’intero romanzo, che i personaggi si pongono e si sentono porre pagina dopo pagina.
Non ci sono risposte, a parole, ma i fatti parlano.
Le scelte quotidiane parlano di noi e ci svelano come esseri umani. Da un punto umano, storico e narrativo, credo non esista scenario più ostile e sfidante, e per questo rivelatore, della fine del 1944 per mettere alla prova integrità e convinzioni, tenacia e credo da ambo le parti in guerra.»
La geometria narrativa di questo romanzo è perfetta, tutto corre lungo un tracciato fatto di dettagli storici ed elementi immaginari perfettamente bilanciati. Come si è sviluppata la trama di questa storia?
«Grazie. Il nucleo del romanzo nasce da un racconto breve che scrissi per i Gialli Mondadori ormai una decina di anni fa.
Conteneva solo la parte di storia ambientata in Germania, ma vi avevo già delineato il personaggio principale del medico e professore universitario di medicina forense Johann Maria Adami, imprigionato come oppositore politico e liberato temporaneamente perché chiamato a risolvere con i mezzi messi a disposizione dalla scienza un mistero legato a una morte sospetta, che potrebbe rendere ancora più fragile il Reich.
Sapevo che prima o poi avrei scritto ancora di Johann, uomo che crede di essersi trasformato in bestia per sopravvivere, ma che ritorna alla sua umanità quando l’SS che gli impone l’incarico, un suo ex allievo, pronuncia il nome della figlia Ada. Anche lei è medico e lotta da sola a Trieste per la propria salvezza e per proteggere un segreto prezioso.
Quella di Ada è la parte “nuova” dell’intreccio, un controcanto alla figura di Johann. I due sono separati, non hanno notizie l’una dell’altro, ma si incontrano nei pensieri e nei ricordi, nelle speranze, nei tanti dubbi e nelle poche certezze che li condurranno a seguire il proprio destino.»
Questo romanzo pone diverse domande che trovo particolarmente attuali: Possiamo tradire i nostri stessi ideali quando tutto attorno a noi è odio e violenza? Possiamo sopravvivere sacrificando la nostra coscienza? Johann e Ada ci servono da esempio?
«La guerra è imbarbarimento da entrambe le parti, volontario o subito, è distruzione di ogni costrutto umano materiale, sociale, culturale. Lo stiamo disimparando da quando la televisione ha portato le immagini dei conflitti più tragici dentro casa nostra e le ha rese quasi normali, perché quotidiane. Espressioni come “guerra chirurgica”, “obiettivi militari”, “perdite minimizzate” ecc. non hanno alcun senso nella realtà, sono pura narrazione, usata per non avvertire il peso delle morti necessariamente inflitte.
Chi resiste alla discesa morale che è esperienza comune della guerra è faro per tutti gli altri. Ma ogni atto ha una o più conseguenze.
Johann ha rinunciato a tutto pur di non ritrattare, pur di non essere complice silente del grande male nazista. Anche alla sua famiglia, anche a sua figlia.
Ada glielo rimprovera, non riesce a perdonarlo. Deve badare a se stessa in una città messa a ferro e fuoco dai nazisti, donna sola (anche gli stupri di guerra sono una parte della storia che non trova spazio nei libri di testo), che ha scelto di resistere in modo nascosto, non aperto come il genitore, ma che passo dopo passo contraddice l’intento dichiarato di non esporsi e rischia tutto, perché il sistema di valori con cui è stata cresciuta non le permette di tacere, di voltarsi dall’altra parte facendo finta di non vedere. Attraversando i medesimi dilemmi etici del padre, finalmente ne comprenderà il valore.
C’è sempre qualcosa di noi da scambiare, da svendere, da perdere per poter attraversare la notte più nera e arrivare all’alba. È un fatto umano e deve appartenere al territorio più intimo della compassione.
In Se questo è un uomo, Primo Levi ha scritto: “Moltissime sono state le vie da noi escogitate e attuate per non morire: tante quanti sono i caratteri umani. Tutte comportano una lotta estenuante di ciascuno contro tutti, e molte una somma non piccola di aberrazioni e di compromessi. Il sopravvivere senza aver rinunciato a nulla del proprio mondo morale, a meno di potenti e diretti interventi della fortuna, non è stato concesso che a pochissimi individui superiori, della stoffa dei martiri e dei santi”.»
Tra le pagine brillano alcuni nomi per lo più sconosciuti che durante la Guerra hanno fatto la differenza: sono le donne della Resistenza. Finalmente si parla anche di loro.
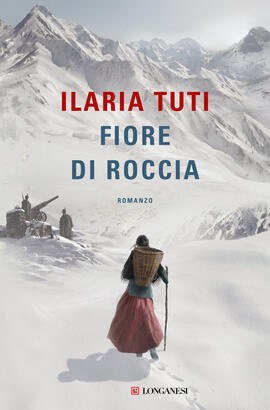
«Tempo fa lessi un articolo, purtroppo non ricordo dove e a firma di chi, in cui era riportato questo dato: in Italia ci sono pressappoco trecento lastre commemorative che ricordano il sacrificio compiuto dagli eroi della Resistenza. Di queste, solo tre fanno riferimento alle donne del movimento. Non ho controllato, ma per statistica e per esperienza direi che non c’è motivo di dubitarne.
Eppure queste donne sono state fondamentali. La storia come ci viene tramandata, soprattutto nei testi scolastici, è piena di omissioni del genere, perché fino a poco tempo fa era scritta solo da uomini, dal loro punto di vista. Durante le mie ricerche storiche mi imbatto spesso in eventi di grandiosa rilevanza per opera femminile.
Ho scritto Fiore di roccia sull’epica impresa delle portatrici carniche e Come vento cucito alla terra sulle prime chirurghe operanti su un campo di battaglia, entrambi ambientati durante la Prima guerra mondiale, per rammentare prima di tutto a me stessa che i diritti di cui godiamo oggi sono il lascito dei passi proibiti e meravigliosamente folli, per il coraggio che richiesero, compiuti dalle nostre ave nemmeno molto tempo fa. Quei passi, rivoluzionari, sono patrimonio dell’umanità.»
Il castello di Kransberg e la Risiera di San Sabba dominano la scena, imponendo un’esperienza di lettura al limite dell’apnea. Le descrizioni sembrano frutto di un brivido provato in prima persona…
«Oggi il castello di Kransberg è utilizzato per l’organizzazione di eventi privati. Il gestore era stupito, quando l’ho contattato per avere informazioni storiche sul maniero.
Alla Risiera di San Sabba di Trieste, invece, torno spesso, almeno ogni due, tre anni. È un luogo che trascende la materia, in cui cammino in silenzio, rifletto, medito. Non è fatto solo di cemento, mattoni e legno: è un sacrario laico, ha una voce propria che, come descrive il personaggio di Ada nel romanzo, è fatta di una singola nota bassa, che risuona dentro e pervade chi è disposto ad ascoltare. Le cellette claustrofobiche, la sagoma del forno crematorio usato dalle SS (unico in Italia, fu fatto saltare durante la ritirata), le finestre delle camerate, il magazzino della spoliazione sono specchi in cui veder riflessi se stessi e la propria coscienza.
Poco tempo fa ci ho portato mia figlia, che ha quasi otto anni. Non è servito spiegarle molto (troppo), il suo istinto di giovane creatura, la spinta alla vita che la abita, si è subito messo all’opera, facendole rifiutare anche solo l’idea che là dentro qualcuno potesse imprigionare un suo simile e farne cenere, disperdendola in mare. Credo che il senso di ciò che è bene e ciò che è male sia innato, è responsabilità di noi adulti proteggere questo seme e farlo germogliare.»
Risplendo non brucio è un romanzo sui generis, che alterna elementi della narrativa gialla con la Storia vera, travalicando ogni etichettatura. Quello che ho percepito è un grido sincopato, quasi un monito a non dimenticare.
«La memoria – personale, collettiva, storica – è uno dei temi a me più cari. Non è solo un modo per onorare chi ci ha preceduto e ci ha lasciato in eredità la libertà che per noi è scontata, rappresenta anche uno strumento educativo per capire e interpretare il mondo che ci circonda, per fissare dei punti di riferimento per orientarci nella sua complessità, per immaginare e costruire il futuro delle generazioni che verranno e delle quali siamo responsabili.
Più il tempo passa, più dobbiamo proteggere la memoria e ciò avviene non lasciandola nelle teche di un museo, ma facendone esperienza di riflessione, di condivisione, di discussione, magari partendo anche dalla lettura di un romanzo che possa accendere la scintilla di curiosità che porterà a visitare quel museo.
Ricordo due parenti con cui ci si ritrovava ai grandi pranzi di famiglia, quelli infiniti dove il più anziano era ottuagenario e qualcun altro aveva appena imparato a camminare. Erano cognati. Uno aveva fatto l’esperienza della Resistenza, l’altro era stato un convinto fascista, tanto che portava ancora i drammaticamente famosi baffetti. Ricordo che in loro presenza a noi bambini – erano i primi anni Ottanta – era vietato chiedere della guerra, persino nominarla per gioco. Venivamo istruiti dalle madri in questo senso, con poche parole.
Credo che l’Italia non abbia mai fatto davvero i conti con il proprio passato e questi conti restano sospesi come un’ombra.
Credo che il bisogno di andare avanti, di ricominciare, di rituffarsi nella vita e lasciarsi dietro le macerie tangibili e intangibili di un conflitto che è stato non solo guerra di conquista, ma soprattutto guerra di ideali, sia costato un prezzo alto: un pezzetto della propria coscienza, per alcuni; la memoria, per altri.»
La Redazione ringrazia Ilaria Tuti per la disponibilità 🙂
Grazie a voi 😊

