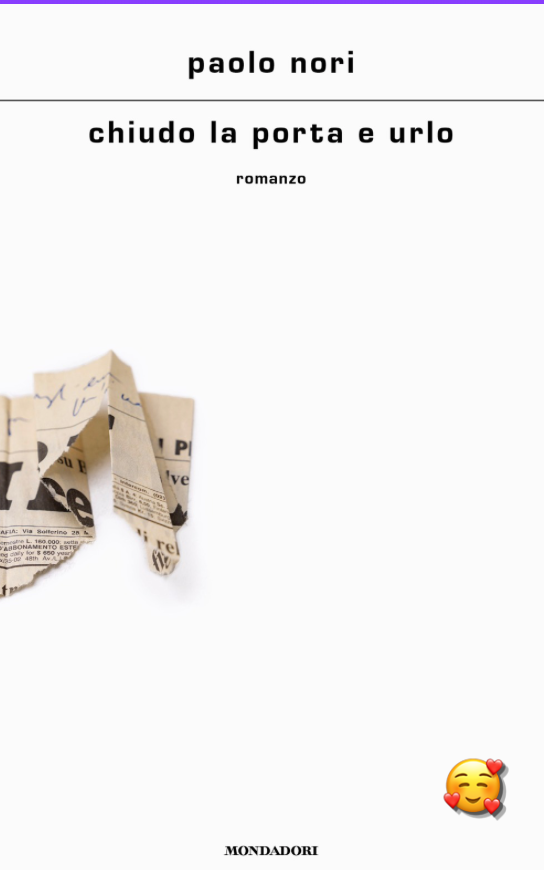Chiudo la porta e urlo
SINOSSI
Raffaello Baldini è un poeta grandissimo eppure pochi sanno chi è, e di quei pochi pochissimi ne hanno riconosciuto la voce. Perché scrive nel bel dialetto di Sant’Arcangelo di Romagna? Ma no.
Paolo Nori ci rammenta che è poeta enorme anche nel bell’italiano con cui il poeta ha sempre tradotto a pie’ di pagina i suoi versi. E quante storie si trascinano appresso quei versi, quante immagini suscitano, quanti personaggi, quanto universo c’è in quel mondo apparentemente piccolo. Come sua consuetudine, Paolo Nori attraversa l’avventura poetica di Baldini quasi come non ci fosse altro intorno, di sé facendo il filtro di una bellezza che viene su come da un fontanile e fa paura, perché ci lascia straniti
Ecco che – non diversamente da quanto è accaduto con Dostoevskji e Achmatova – l’immaginazione di Baldini si scioglie dentro quella di Nori, fatta com’è di caratteri e di accadimenti apparentemente minimi: i morti che “non dicono niente e sanno tutto”, gli uomini che invece di calarsi gli anni se li crescono, lo stare lì di una donna davanti alla circonvallazione per guardare “che passa il mondo”.
Fra spinte e controspinte, fra il “cominciamo pure” e il “continuiamo pure” che ricorrono a battere il ritmo, impariamo che, sempre più, la scrittura di Nori è la messa a fuoco progressiva di un carattere, il suo: il suo essere “coglione”, il suo essere “bastiancontrario”, il suo essere “matto come un russo”, il suo essere innamorato di un poeta come Raffaello Baldini, il suo magone davanti alla casa dei Nori come fosse una scatola di bottoni, il suo stare a vedere la vita come va avanti a ogni svolto imprevisto dello stare al mondo.
RECENSIONE
Dopo essere entrato – non in punta di piedi ma con tutta la sua biografia – nelle vite di Dostoevskij ed Achmatova, Paolo Nori ci racconta (raccontandosi) Raffaello Baldini, poeta romagnolo.
Racconta Baldini parlando di se stesso, della Battaglia, di Togliatti (chi legge Nori sa che con questi due nomignoli lui chiama la figlia e la mamma di sua figlia), dei suoi genitori, e anche della nonna Carmela. La divagazione è la cifra espressiva nei romanzi di Paolo Nori e l’unico modo per entrare in questo testo è farsi prendere a braccetto dall’autore e passeggiare nei suoi boschi narrativi, che sono fatti di affabulazione, ironia, citazioni, ed improvvise e toccanti confessioni.
«I libri, c’è da dire, non mi piacciono tanto per quello che dicono ma per come mi fanno sentire» (p. 39) scrive Nori ed è proprio questo lo spirito che lo guida in queste divagazioni, che diventano frammenti, ognuno dei quali è numerato con il numero del capitolo e poi del paragrafo, ad esempio:
«1.47 Santarcangelo e le Langhe.
La cosa che mi aveva colpito, ero piccolo, facevo le medie, è che Pavese, la sua letteratura, quella poesia lì bellissima, la tirava fuori dai posti dove era nato, le Langhe, dai suoi posti, non c’era bisogno del giro del mondo in ottanta giorni, dei pirati di Mompracem, di uno stato del sud degli Stati Uniti d’America o di Pietroburgo: bastavano le Langhe.
E Baldini, uguale» (p. 39).
Baldini, pur avendo vissuto più di metà della sua vita a Milano, scriveva di due cose, continua Nori: Santarcangelo e l’universo.
E la scelta di scrivere in dialetto è restare fedele alla provincia eppure parlare a tutti, perché è la lingua del cuore che riesce a superare i particolarismi. È la lingua di Baldini ed è la lingua di Nori, anche se, a voler essere precisi, gli emiliani quando crollano, crollano da soli, dentro le stanze, mentre i romagnoli, chiudono la porta e urlano.
Questo romanzo, Chiudo la porta e urlo, che forse in fondo “romanzo” non è, ci parla insieme di urla ma ancor più di crolli, narrati con acuta sincerità. Il punto che avvicina, probabilmente, la poetica di Nori a quella di Baldini, è riuscire a mostrare squarci di verità e domande profonde, attraverso le cose umili, gli stendini e i barattoli, i termosifoni spenti e i post-it sul frigorifero.
Al centro di questo romanzo-non romanzo, che è un monologo affabulante in cui incontriamo Šklovskij e Gončarov, Achmatova e Pasternak e tanti tanti altri, vi è il rapporto che lega letteratura e vita. Perché l’arte, come diceva Šklovskij, resuscita la vita.
«L’uomo è così occupato dalla vita, che si dimentica di viverla. Dice sempre Domani, domani. E questa è la vera morte. Qual è invece il grande successo dell’arte? È la vita. Una vita che si può vedere, sentire, vivere in modo palpabile» (p. 72). La poesia di Raffaello Baldini mostra, senza teoremi o paroloni, lo Stare al mondo. «Come, in quella poesia di Baldini, quando “l’aria allora è diventata così leggera che sul crocicchio s’è sentito pigolare il campanello arrugginito di una bicicletta, e laggiù, ma lontano, volare un aeroplano sopra il mare» (p. 72).
La letteratura svela la vita, ce la mostra nella sua nudità, non velata dall’abitudine.
La domanda che si fa Nori è la stessa che si faceva Oblomov, il protagonista del romanzo di Ivan Gončarov, che «quando studiava, da ragazzo, Oblomov non capiva bene il motivo per cui gli facevano leggere e gli facevano studiare la materia che gli facevano studiare e continuamente si chiedeva nella sua testa, Ma quand’è che si vive? Io mi ricordo benissimo, quand’ero un ragazzo che mi chiedevo Ma quand’è che si vive? Ho passato degli anni a chiedermi Ma quand’è che si vive? E ancora adesso, ogni tanto, me lo chiedo, Ma quand’è che si vive? Che è proprio una bella domanda: Quand’è che si vive?» (p. 71)
Ecco: la letteratura per Nori – e questo ce lo spiega anche con i lunghi frammenti che riproducono le poesie di Baldini – non parla di cose straordinarie, o meglio parla di cose straordinarie ma che non sono necessariamente battaglie, viaggi in terre inesplorate o vicende epiche.
Le cose straordinarie che la letteratura ci consente di vedere (e salvare) sono la nostra casa, il nostro cane, la nonna Carmela, il mattino alla finestra. Gli autori che sceglie Nori per il suo cammino, gli «fanno vedere le cose che sono in casa mia, che mi circondano, come se le vedessi per la prima volta, non rendono visibile l’invisibile, rendono visibile il visibile» (p. 198)
Con una prosa che riproduce il parlato, Paolo Nori ci trasmette non forse un’immagine completa e a tutto tondo di Baldini, ma il nucleo vitale del suo essere uomo e poeta e fra le pagine che si sussegguono in modo frammentario e apparentemente perdendo il filo, si ritrovano gli echi di pensieri e vite che costituiscono la trama della letteratura, verso la quale Nori con spiazzante semplicità riesce sempre a proclamare il suo amore.
AUTORE
Paolo Nori (Parma, 1963), laureato in letteratura russa, ha pubblicato romanzi e saggi, tra i quali Bassotuba non c’è (1999), Si chiama Francesca, questo romanzo (2002), Noi la farem vendetta (2006), I malcontenti (2010), I russi sono matti (2019), Che dispiacere (2020) Sanguina ancora (2021) e Vi avverto che vivo per l’ultima volta (2023). Ha tradotto e curato opere, tra gli altri, di Puškin, Gogol’, Lermontov, Turgenev, Tolstoj, Čechov, Dostoevskij, Bulgakov, Chlebnikov, Charms.